Il M5S ha depositato un’interrogazione con cui chiede che la Provincia revisioni il sistema degli strumenti di partecipazione popolare in materia ambientale perché quelli che abbiamo sembrano fatti per prendere in giro le persone.
Il sistema costruito in Trentino per garantire ai cittadini il diritto di esprimersi rispetto alle grandi tematiche ambientali è fallimentare. Se dal punto di vista teorico le regole ci sono, all’atto pratico si scopre che gli istituti previsti per dare voce ai cittadini, dai referendum alla partecipazione del pubblico alle Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA) e alle Valutazioni d’Impatto Strategico non vengono attuate (ultimo esempio, riaccensione del cementificio di Sarche) o al limite il tutto viene implementato in modo da garantire i risultati desiderati da chi ha interesse a realizzare le grandi opere (vedasi bypass ferroviario di Trento). Quando poi i cittadini riescono contro ogni pronostico a superare tutti gli ostacoli posti sul loro percorso allora i ventriloqui delle lobby passano direttamente al sabotaggio. Ciò è avvenuto in occasione del referendum sul distretto biologico trentino, rinviato, osteggiato e depotenziato in modo da rendere impossibile conseguire il quorum ma anche con l’attuazione della legge sul Parco Agricolo del Garda trentino, completamente abbandonata dopo che il disegno di legge di iniziativa popolare che avrebbe dovuto istituire il Parco era stato votato in Consiglio provinciale. La dimostrazione plastica che nella democratura trentina, il volere dei cittadini conta molto meno di quello dei lobbisti.
Insomma, gli esempi di cattivo funzionamento degli strumenti di partecipazione ambientale alla tutela dell’ambiente in Trentino sono tanti, troppi per elencarli tutti. Preso atto della realtà bisogna chiedersi come intervenire per migliorare le cose. La nostra risposta è che servono riforme radicali, perché non basta ascoltare i comitati e i cittadini pro forma per poi andare a prendere ordini dai potentati di turno.
Abbiamo iniziato con un’interrogazione, ma da qui alla fine della legislatura non mancheremo di far sentire ancora la nostra voce su questi temi fondamentali per il benessere e la vita di tutti i trentini.
* * * * *
Segue l’interrogazione 3731/XVI del 20 maggio 2022 “Analisi del funzionamento e dell’efficacia degli strumenti di partecipazione popolare rispetto ai processi decisionali in materia di ambiente”
La Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale è stata firmata ad Århus, in Danimarca, il 25 giugno 1998 dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri richiamando il primo principio della Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, il decimo principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo, le risoluzioni dell’Assemblea generale nn. 37/7, del 28 ottobre 1982, sulla Carta mondiale della natura e 45/94, del 14 dicembre 1990, sulla necessità di garantire un ambiente sano per il benessere degli individui e la Carta europea sull’ambiente e la salute, adottata l’8 dicembre 1989 a Francoforte sul Meno (Germania) in occasione della Prima conferenza europea sull’ambiente e la salute dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 2001 (L. 108/2001);
la Convenzione, in vigore 2001, parte dall’idea che un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell’ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. A questo fine, la convenzione prevede tre aree di intervento: (1) assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’ambiente detenute dalle autorità pubbliche, (2) favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali che influiscono sull’ambiente e (3) estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale;
il secondo pilastro della Convenzione, sancito dagli artt. 6 (Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche), 7 (Partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia ambientale) e 8 (Partecipazione del pubblico all’elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale) è stato recepito dalla direttiva europea 2003/35/CE che è divenuta cogente nell’ordinamento italiano attraverso il Codice dell’ambiente (D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.);
il D.lgs 152/2006 è conforme all’obbligo di coinvolgere il pubblico nelle decisioni relative all’autorizzazione di attività che possono avere effetti significativi sull’ambiente, regola infatti la partecipazione del pubblico alle Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA) e alle Valutazioni d’Impatto Strategico (VAS) ovvero quei processi che l’autorità pubblica deve necessariamente portare a termine prima di autorizzare opere, piani o programmi che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente;
nel Quinto aggiornamento del Rapporto Nazionale per l’attuazione della Convenzione di Aarhus in Italia (2021) adottato dal Ministero della Transizione Ecologica, nella parte “XXIV. Sforzi compiuti per promuovere la partecipazione pubblica durante la preparazione di regolamenti e regole che possono avere un significativo effetto sull’ambiente, in base all’articolo 8”, si specifica che allo stato corrente non esiste una procedura istituzionale che disciplini la partecipazione del pubblico alla preparazione di atti legislativi di livello nazionale. Sono comunque stati istituiti alcuni meccanismi che consentono il coinvolgimento del pubblico nelle attività legislative. Ad esempio durante le “audizioni parlamentari” sono inviati rappresentanti del pubblico (o loro associazioni) che possono esprimere pareri su progetti normativi in discussione a livello di commissione parlamentare. I soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni anche “per via telematica”, secondo le modalità previste dal D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni. Nell’aggiornamento si specifica che altri strumenti per le consultazioni pubbliche, pur con i limiti strutturali che ne rendono efficace l’utilizzo, sono la petizione, l’iniziativa popolare e il referendum. Gli stessi strumenti sono previsti sia a livello nazionale che locale;
nella parte “XXV. Descrivere le difficoltà che si sono incontrate nell’attuazione dell’articolo 8” si sottolinea che a volte risulta complesso per le Amministrazioni attivare in modo sistematico processi di partecipazione diretta che seguano regole prevedibili e strutturate lungo tutto l’iter regolamentare. La frammentarietà del tessuto associativo, non sempre aggregato in network di secondo livello, moltiplica la quantità di interlocutori e ne riduce, al tempo stesso, la rappresentatività.
a livello provinciale si può affermare che la situazione non sia diversa da quella nazionale. La legge provinciale del 5 marzo 2003, n.3 “Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali” è una legge che rimane obsoleta, riformata solo parzialmente nel giugno 2019 senza peraltro informare la Commissione di Venezia per una valutazione conclusiva (si veda Opinion Venice Commission No. 797/2014);
per quanto attiene le leggi di iniziativa popolare, dall’anno dell’approvazione della lp 3/2003, nel corso di tre legislature sono state presentate n. 6 proposte di legge di iniziativa popolare, una percentuale prossima allo zero rispetto al numero complessivo delle iniziative legislative promosse dalla Giunta e dal Consiglio. Tra le sei proposte di legge di iniziativa popolare: quattro sono state rigettate, una è stata accorpata ad un altro disegno di legge, mentre un’altra, riguardante il Distretto agricolo del Garda trentino e quindi un tema di natura ambientale, è stata approvata e convertita in legge senza tuttavia essere mai stata attuata (Legge provinciale 4 agosto 2008, n. 15 recante Distretto agricolo del Garda trentino);
per quanto riguarda infine le consultazioni dei soggetti interessati si registra la buona prassi in vigore in Consiglio di ascoltare le associazioni ambientaliste in alcuni processi legislativi anche se, non raramente, i tempi di preavviso per l’espressione di pareri e osservazioni sono insufficienti (vedasi Lettera di protesta indirizzata ai consiglieri da parte di Legambiente, Italia Nostra e WWF del Trentino del 18 maggio su riduzione tempi per la presentazione di osservazioni sul disegno di legge 141/XVI in materia di valutazioni ambientale). Si deve inoltre rilevare che l’informazione prodotta e messa a disposizione della cittadinanza riguardo al contenuto delle audizioni è limitata: i verbali sintetici delle sedute di commissione non sono pubblicati online (Int. n. 574/XVI); le osservazioni scritte depositate dai diversi soggetti come professori universitari, associazioni, sindacati, organizzazioni di categoria e di vario altro tipo non sono pubblicate nella scheda dei disegni di legge (Int n. 639/XVI); non sono disposte le videoregistrazioni degli interventi o la resocontazione integrale (Int. n. 650/XVI);
la stessa situazione si evidenzia nella trattazione delle petizioni che, incidentalmente, nella maggior parte dei casi riguardano richieste di tutela e di difesa del territorio e dell’ambiente. E’ vero che l’iter delle petizioni viene normalmente concluso e che ne viene data notizia anche tramite note appositamente diramate dall’ufficio stampa del Consiglio provinciale, tuttavia la documentazione prodotta nel corso della discussione non viene messa a disposizione nella banca dati collegata alla scheda della petizione e, soprattutto, solo sporadicamente l’esito della trattazione delle petizioni produce risultati effettivi e vincolanti rispetto all’operato del potere esecutivo;
a livello comunale e di comunità di valle la situazione non è meno preoccupante, al contrario per molti aspetti è desolante. Gli istituti di partecipazione popolare sono previsti dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (artt. 5-12-13-14-15) e recepiti dagli Statuti comunali e delle comunità, ma nella maggioranza dei casi non sono disciplinati dai regolamenti attuativi (si veda Ordine del giorno 9/XVI). Troppo spesso le iniziative dei cittadini promosse a livello locale tramite istanze, petizioni, proposte di delibera popolare, assemblee o referendum restano lettera morta e non hanno alcun tipo di riscontro da parte degli organi di rappresentanza degli enti locali. Gli istituti di partecipazione popolare sono pertanto tendenzialmente disattesi con qualche rarissima eccezione che conferma le regola;
l’ordine del giorno 78/XVI dell’11 settembre 2019 “Rapporto provinciale biennale sull’attuazione dei principi della Convenzione di Aarhus riguardante il maggior coinvolgimento dei cittadini sui problemi di tipo ambientale” impegna la Giunta ad integrare il rapporto annuale sullo stato dell’ambiente, che l’Agenzia per la protezione dell’ambiente redige ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale n. 11 del 1995, con una parte relativa all’attuazione dei principi della Convenzione di Aarhus che contenga, in particolare, la descrizione dei risultati conseguiti nelle tre aree di intervento: accesso del pubblico alle informazioni, partecipazione dei cittadini nei processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale. Il documento dovrà altresì contenere un approfondimento specifico relativo all’individuazione delle difficoltà e criticità che ostacolano una piena partecipazione della cittadinanza alle decisioni, ai piani e ai programmi ambientali sviluppati anche a livello comunale o presso le comunità al fine di assicurare la piena attuazione dei principi della Convenzione con specifico riferimento agli articoli 6, 7 e 8. Il punto 2 dell’ordine del giorno impegna la Giunta a sottoporre all’attenzione del Consiglio provinciale il documento di cui al punto 1 che potrà essere oggetto di specifico dibattito e confronto nell’ambito della commissione permanente competente in materia di ambiente;
Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per sapere
- se siano mai stati adottati e vi sia l’intenzione di adottare meccanismi per valutare l’efficacia degli strumenti di partecipazione popolare previsti dalla normativa provinciale e come gli stessi si inseriscono ed incidono nei processi decisionali e legislativi;
- se, anche alla luce delle petizioni, iniziative popolari e richieste di referendum depositate nel corso della legislatura, non ritiene di procedere ad un’analisi del funzionamento e dell’efficacia degli strumenti di partecipazione popolare previsti dalle norme provinciali rispetto ai processi decisionali in materia di ambiente;
- se non ritenga di condividere le note attuative rispetto agli impegni dell’ordine del giorno 78/XVI nonché le risultanze delle valutazioni sull’efficacia degli strumenti di partecipazione popolare in ordine ai processi decisionali in materia ambientale con il Ministero della Transizione Ecologica affinché ne possa tenere conto nella predisposizione periodica del Rapporto Nazionale per l’attuazione della Convenzione di Aarhus in Italia
* * * * *
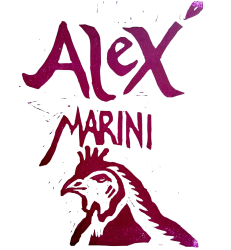

2 Replies to “Tutela dell’ambiente attraverso la partecipazione popolare: il sistema trentino non funziona e va riformato”